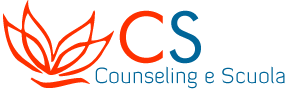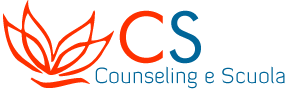Perché Counseling e Scuola
In un tempo molto breve c'è stato il passaggio da una società relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti che hanno portato a una modificazione del paesaggio educativo e dell’orizzonte culturale della scuola e della famiglia, definendo nuovi scenari imprevedibili e, spesso, difficili da controllare.
All’interno del complesso paesaggio educativo diventa necessaria una ridefinizione degli spazi relazionali, soprattutto tra le due principali agenzie formative, scuola e famiglia, secondo un circuito di scambio, di rispetto dei relativi ambiti di esperienza e di valorizzazione delle esperienze.
La complessità che connota, quindi, la vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie rende necessario immaginare un nuovo orizzonte culturale, in cui la promozione della maturazione della persona sia la priorità della comunità educante.
Diventa così necessario che tutti gli elementi del sistema si attivino per promuovere lo sviluppo nella e della comunità, immaginando un progetto evolutivo di crescita e maturazione nell’ottica dell’empowerment e dell’autoefficacia.
Ed è proprio in questo contesto che la pratica del counselling scolastico esprime al meglio le sue caratteristiche come mediatore dei processi di trasformazione, come opportunità di crescita in situazioni “critiche”, come intervento di aiuto per l’individuazione e l’uso delle risorse soggettive e comunitarie disponibili, al fine di creare comunità educative resilienti.
Fra le finalità di ogni intervento di counselling scolastico c’è quella di valorizzare le risorse dell’individuo, dell’ambiente e della comunità scolastica al fine di permettere agli insegnanti, ai genitori e agli alunni di governare processi di cambiamento all’interno della complessità educativa.